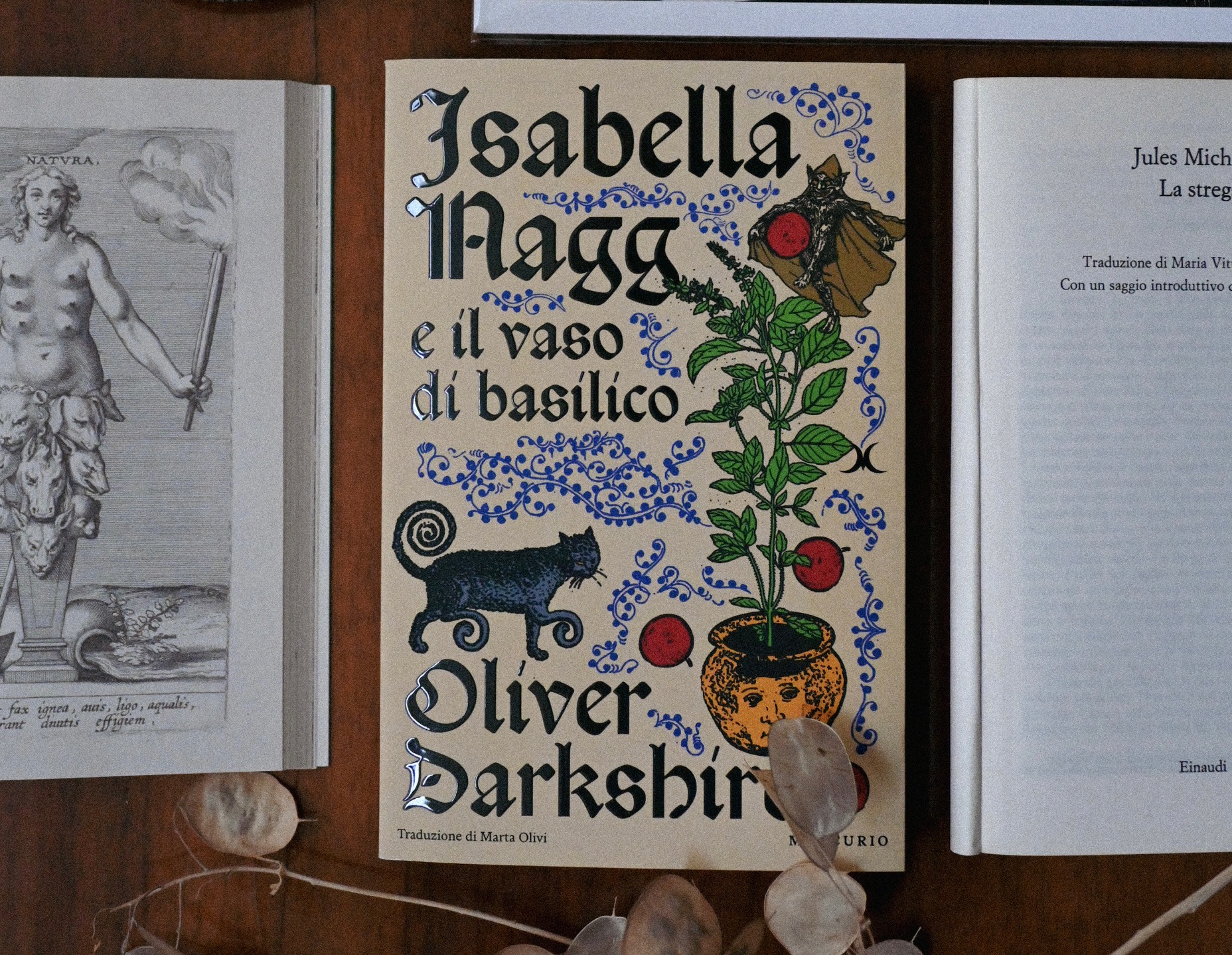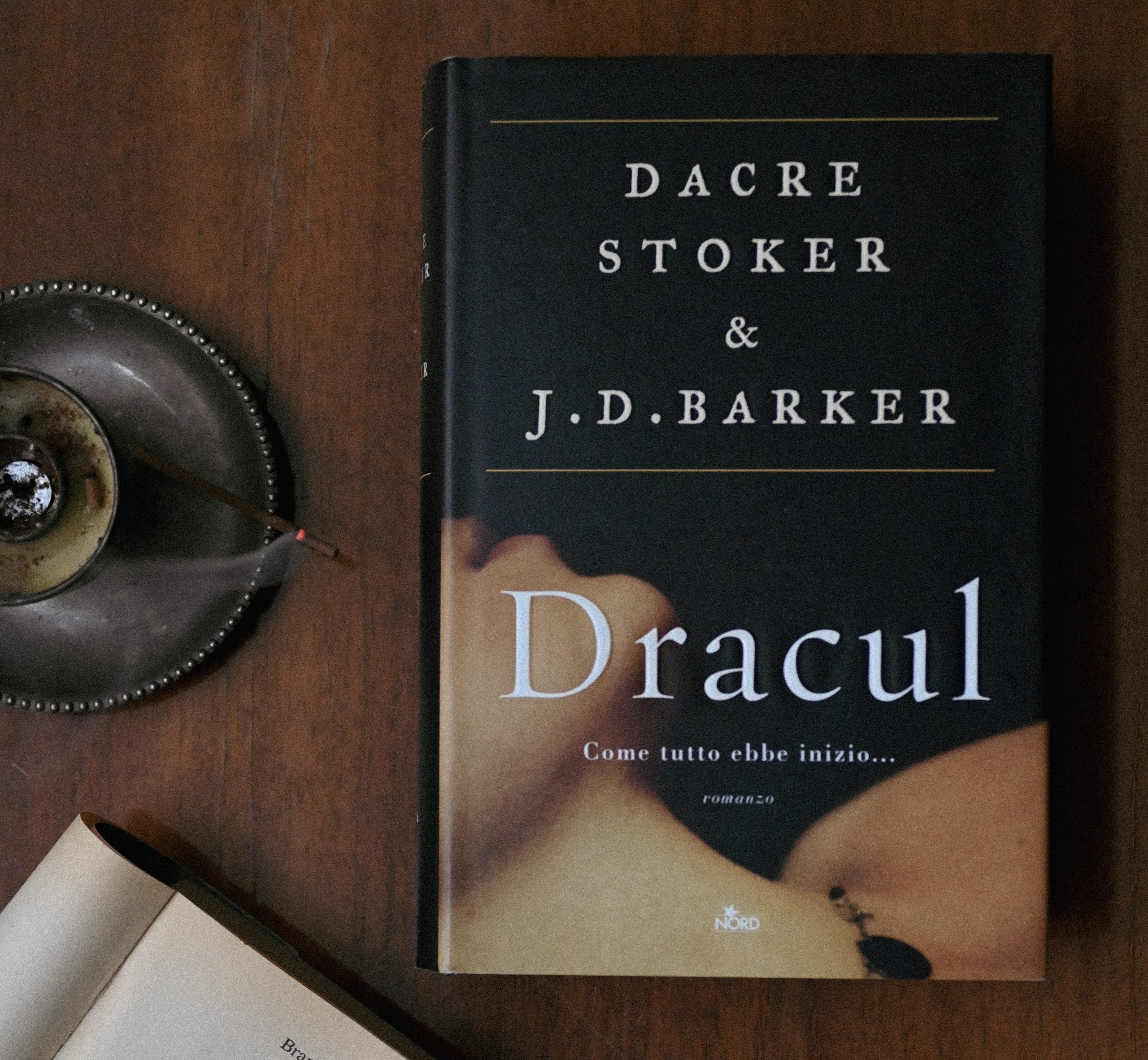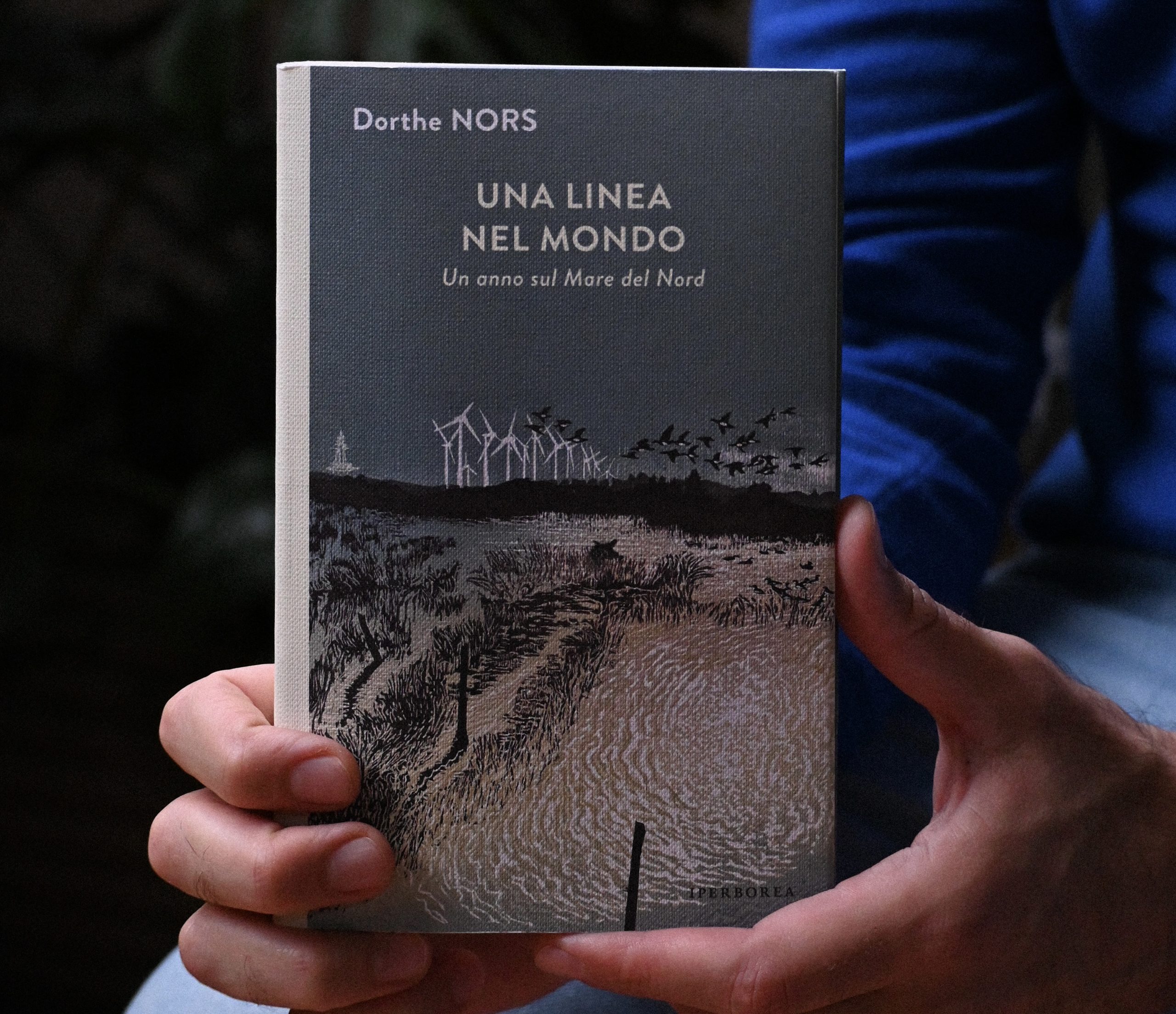Iniziai ad andare in “ibernazione” come meglio potevo a metà giugno del 2000, a ventisei anni. Vidi l’estate morire e l’autunno diventare freddo e grigio da una stecca rotta nella veneziana.

Ci sono momenti nella vita in cui vivere diventa davvero difficile. Compiere qualsiasi azione richiede uno sforzo immenso, e trovare un motivo per andare avanti, anche solo per un altro minuto, sembra un’impresa quasi impossibile. Ognuno affronta il dolore a modo suo: c’è chi lo combatte, chi lo evita e chi, invece, vi soccombe.
La protagonista del romanzo Il mio anno di riposo e oblio, scritto da Ottessa Moshfegh, sceglie un approccio estremo: decide di andare in letargo, imbottendosi di psicofarmaci — Trazodone, Ambien, Nembutal. Il suo obiettivo è cancellare i pensieri per rendere la vita più tollerabile, rallentando il cervello. Vuole dormire per un anno intero, per poi risvegliarsi e guardare al passato come a un sogno. Solo allora, crede, potrà ricominciare senza rimpianti, più forte di prima, rigenerata dalla beatitudine e dalla pace accumulate durante il mio anno di riposo e oblio.
La protagonista, di cui non conosciamo il nome, è profondamente infelice — e come potrebbe non esserlo, dopo aver visto il padre morire di cancro e la madre, alcolizzata, togliersi la vita? Come se non bastasse, ha assistito anche all’inaspettata morte della sua migliore amica d’infanzia. Prima di tutto questo, era una giovane donna ricca dell’Upper East Side di Manhattan, impegnata in una routine fatta di trattamenti estetici, palestra esclusiva, hammam, scarpe dolorose e serate fuori: “Lavaggio del colon e del viso, colpi di luce, allenamento in una palestra costosissima seguito da ammollo nell’hammām finché non ci vedevo più niente, e poi di sera uscivo con scarpe che mi tagliavano i piedi e mi facevano venire la sciatica. Ogni tanto conoscevo uomini interessanti in galleria. Ogni tanto scopavo in giro, uscivo di più, poi sempre meno”.
È cresciuta senza affetto, lasciata sola da una madre chiusa in camera a ubriacarsi. Avrebbe potuto suicidarsi, per mettere fine a quel dolore insopportabile. Invece ha scelto di preservarsi. L’ibernazione le avrebbe salvato la vita.
La discesa negli inferi del dolore è stata rapida, ma non immediata. Per un po’ ha continuato a vivere come sempre: lavorava in una galleria d’arte, incontrava la sua amica Reva, si lasciava e tornava con Trevor. Ma il bisogno di oblio e l’abuso di farmaci l’hanno portata ad allontanarsi da tutto e da tutti. Si rinchiude in casa con l’intenzione di non uscirne più. Ordina online ciò di cui ha bisogno, imposta il pagamento automatico delle bollette. L’unica a farle visita di tanto in tanto è Reva, una ragazza insicura, bulimica, sempre in cerca di approvazione. Esce solo per andare nel piccolo negozio egiziano sotto casa o per recarsi dalla sua psichiatra.
Era questo il bello di dormire, la realtà si distaccava e mi arrivava nella mente in modo casuale come un film o un sogno. Era facile ignorare quello che non mi riguardava […] Sarebbero potuti arrivare gli extraterrestri, un’invasione di locuste, e io me ne sarei sì accorta, ma non mi avrebbe dato nessuna preoccupazione.
È costretta a vedere la dottoressa Tuttle, l’unico modo per ottenere le prescrizioni mediche. Trova una scusa per evitare di andarci ogni settimana, limitandosi a una visita mensile, e durante le sedute le racconta bugie: dice di non dormire, di avere un’insonnia terribile. In realtà, dorme già per intere giornate. La dottoressa Tuttle incarna tutto ciò che un medico non dovrebbe essere: distratta, superficiale, ripete sempre le stesse domande — “I tuoi genitori come stanno?” — e prescrive qualsiasi farmaco le venga richiesto, senza battere ciglio.
Le giornate che preferivo erano quelle che passavano senza che me ne accorgessi.
Il romanzo segue tutto il percorso della protagonista, e Ottessa Moshfegh lo racconta con uno stile spiazzante, a tratti delirante. L’intera storia ha un tono surreale, mescolando ironia, cinismo, irriverenza e profonda drammaticità. È un libro scritto in modo magistrale: la sensazione di ottundimento, di annebbiamento mentale, è resa alla perfezione. Chi pensa che questo romanzo non abbia una trama si sbaglia. Moshfegh conosce alla perfezione le tecniche narrative e le utilizza con consapevolezza.
Il mio anno di riposo e oblio è strutturato in fasi ben definite, che corrispondono al percorso della protagonista verso la rinascita. La prima fase è il sonno: l’uso dei sonniferi le consente di dormire gran parte della giornata, evitando così pensieri, ansie e dolore. Mangia cibo spazzatura, non si lava, vive nel disordine, guarda film in continuazione.
Poi arriva l’insonnia, la minaccia che rovina i suoi piani: l’assuefazione ai farmaci. Essere svegli è il peggiore dei mali, perché significa ricordare, soffrire, sentirsi sopraffatti. L’unica soluzione è passare a farmaci più forti, che la portano alla fase successiva: l’oblio.
Questa è la fase più pericolosa. La protagonista si muove ai limiti della coscienza: realtà e sogno si confondono, le azioni sembrano compiute al buio, senza memoria. È come camminare su un filo: basta un passo falso per sparire. Ma è anche la fase cruciale, quella che, se superata, conduce all’ultima: la rinascita.
C’è un elemento curioso in Il mio anno di riposo e oblio: l’ultima pagina. In essa, il lettore trova un senso più profondo all’intera vicenda, collegato a un evento storico che ha segnato non solo gli Stati Uniti, ma il mondo intero: l’attentato alle Torri Gemelle dell’11 settembre 2001. L’evento avviene pochi mesi dopo il risveglio della protagonista, e diventa un punto di riflessione sul dolore e sul modo in cui lo affrontiamo. Un finale che accappona la pelle.
Eccola, un essere umano che si tuffa nell’ignoto, ed è perfettamente sveglia.
Se ti è piaciuto lascia un cuore!