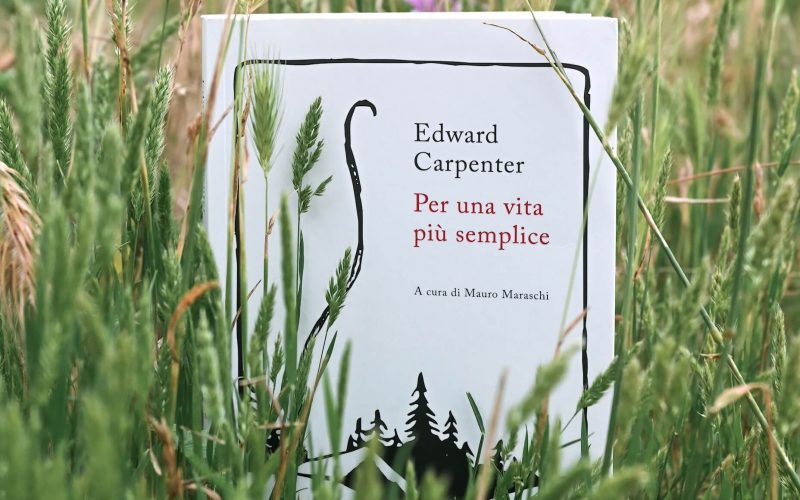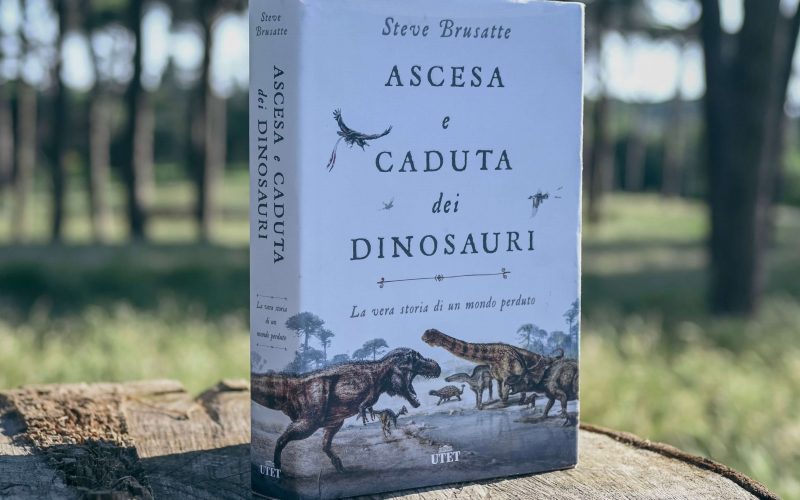Le vergini suicide di Jeffrey Eugenides si apre in maniera inquietante, con un espediente narrativo che svela il finale già dall’incipit: La mattina che si uccise anche l’ultima figlia dei Lisbon (stavolta toccava a Mary: sonniferi, come Therese), i due infermieri del pronto soccorso entrarono in casa sapendo con esattezza dove si trovavano il cassetto dei coltelli, il forno a gas e la trave del seminterrato a cui si poteva annodare una corda. L’autore ci fa capire non solo che tutte le figlie dei Lisbon sono morte suicide, ma ci elenca anche una serie di dettagli che aumentano il senso di tragedia. Sonniferi, il cassetto dei coltelli, il forno a gas, la trave a cui impiccarsi. È così che si sono uccise le sorelle Lisbon? Qualche riga più sotto, il racconto torna a seguire un ordine cronologico, dal primo tentativo di suicidio, quello di Cecilia, la più piccola, di soli tredici anni, con un rasoio nella vasca da bagno.
I coniugi Lisbon hanno cinque figlie, Cecilia, Lux, Bonnie, Mary e Therese, di rispettivamente tredici, quattordici, quindici, sedici e diciassette anni. Si tolgono la vita nel giro di un anno. Una trama terribile che potrebbe focalizzare la sua potenza soltanto sul dolore della famiglia, sul senso di inquietudine che porta la morte per suicidio e su i motivi di tale gesto. Jeffrey Eugenides però alza l’asticella, ed è questo che ha reso cult il romanzo. A raccontare la storia delle sorelle Lisbon è una voce corale, quella di un gruppo di ragazzi, che a vent’anni dalla tragedia provano ancora a penetrarne il mistero, per comprenderlo. Il lettore non vive il turbamento della vicenda dal punto di vista dei coniugi Lisbon o di una delle cinque figlie, ma dal punto di vista dei ragazzi, ormai cresciuti, che all’epoca dei fatti erano perdutamente innamorati e ammaliati dalle sorelle Lisbon. Questa scelta di racconto rende il mistero tale anche per noi lettori; non scopriremo mai le vere motivazioni che hanno portato le ragazze a uccidersi – possiamo ipotizzarle -, se non capire soltanto quanto la loro morte abbia influito sui ragazzi e sul vicinato.
Chi poteva sapere cosa pensavano o ciò che provavano? […] rifuggivano dalla nostra presenza, da quella delle altre ragazze, del loro padre, e le vedevamo solo per caso, ferme in cortile sotto una pioggerella minuta, che mordevano la stessa focaccina guardando il cielo, senza curarsi dell’acqua che poco per volta le bagnava fino alle ossa.
Le sorelle Lisbon costituiscono il vero fascino del romanzo. Il loro modo di comportarsi, di vestirsi, di apparire e scomparire, di discostarsi dai coetanei e dalle stesse figure genitoriali, le rendono esseri misteriosi, quasi ultraterreni. Si muovono sempre insieme, sono una massa uniforme, un’unica entità, pur essendo ognuna di loro completamente diversa dall’altra, perfettamente distinguibili per le loro caratteristiche fisiche e caratteriali. La descrizione delle sorelle non è falsata, l’autore non spinge affinché appaiano eteree, tutt’altro. Sono sì belle, ma imperfette: il colorito giallastro e il naso affilato da monaca di Bonnie, le fattezze marcate di Therese, guance e occhi bovini, la peluria sul labbro di Mary. Lux era l’unica che non smentiva l’idea che ci si era fatti delle sorelle Lisbon. Sprizzava salute e malizia da tutti i pori.
Cecilia in queste descrizioni non appare, è la prima che si suicida. Di lei sappiamo che ha gli occhi color girasole e che rappresenta il pulsante di accensione dell’ingranaggio mortale. La morte delle altre sorelle sembra, infatti, il compimento di un rito, un’alleanza, una promessa sigillata tra loro. Quell’unica entità non può sopravvivere se viene a mancare anche solo una di loro. Ogni loro azione è una danza collettiva, un sabba di streghe e Jeffrey Eugenides non fa nulla per smentirlo, anzi calca la mano per rendere la casa Lisbon una dimora stregata. Eravamo avvezzi a vedere i pipistrelli che volteggiavano su quella casa, planando a zig zag mentre le ragazze strillavano e si coprivano i capelli lunghi. Sul tetto c’è una perenne nuvola nera, durante l’inverno gli alberi del giardino incurvano i rami verso la casa come a volerla celare allo sguardo. Le tapparelle sono tutte serrate, soltanto raramente una mano dall’interno ne solleva uno spiffero per puntare un occhio fuori. Potrebbe essere l’occhio di ognuna di loro.
Quella vecchia strega le aveva messe sotto chiave di nuovo.
La vecchia strega è la signora Lisbon, una signora bigotta che ascolta soltanto musica religiosa e pretende che le figlie seguano il suo esempio. Impone loro rigide regole e smorza ogni entusiasmo adolescenziale, vietando vestitini o qualsiasi indumento da lei considerato volgare. Quando non riesce a contenere la ribellione delle figlie le chiude in casa, sigillando porte e finestre. Il signor Lisbon insegna nella stessa scuola frequentata dalle figlie, e questo rappresenta un ulteriore prigione per le adolescenti, non potendo sfogare le loro personalità nemmeno nell’ambiente scolastico.
I ragazzi che raccontano la storia, ormai adulti, conservano ancora alcuni oggetti trafugati dalla casa Lisbon, li chiamano i reperti. Il loro massimo desiderio, durante l’anno dei suicidi, era poter avere qualsiasi tipo di contatto con le sorelle Lisbon. Perdutamente innamorati avrebbero voluto invitarle al ballo, portarle al cinema, o anche solo avere la possibilità di scambiare una parola. Il fascino delle sorelle, la loro astrazione ed estraneità, è troppo grande da non renderle oggetto di culto, e i loro oggetti vere e proprie reliquie. Più volte i ragazzi di nascosto si erano intrufolati dentro la casa per rubare qualcosa, l’unico modo per averle e venerarle. L’unico modo per sentire il loro odore e sognarle. Quando la signora Lisbon imprigionò le figlie, si trasformarono in eroi pronti a salvarle, per scappare insieme e farsi una vita con loro. Si sarebbero spinti a fare qualsiasi gesto, oltre agli innocui segnali luminosi e a un botta e risposta di canzoni. Questa è anche una delle parti più belle e profonde del romanzo, in cui emerge il bisogno delle ragazze di amare ed essere amate, di poter vivere una vita normale, libere di potersi esprimere. Le melodie, una dopo l’altra, pulsavano di dolore segreto.
Dopo vent’anni ancora non sono stati in grado di risolvere il mistero di quei suicidi che hanno cambiato per sempre anche la loro vita. Perché le sorelle hanno deciso di suicidarsi? Non avevano alternative al loro male? O lo hanno fatto in maniera serena, come se stessero andando incontro al loro destino? Era predisposizione genetica? Un’azione fatta nell’impeto del momento? La causa è forse da ricercare nell’oppressione dell’ambiente familiare o del contesto storico?
Jeffrey Eugenides ha scritto un romanzo potente, pieno di inquietudine e di bellezza. La morte raccontata si veste d’opera d’arte, di creazione collettiva, è un gesto potente per esprimere la propria interiorità. La scrittura non preme mai sulla commiserazione, sul dolore facile, non si propone di studiare le cause della morte, è precisa ed elegante, riempie le pagine di mistero. Quel mistero che ricopre l’intero romanzo di un velo funebre, opprimente, che mette un peso sul cuore, e ogni lettore è libero di giungere alle proprie conclusioni o soltanto di prenderne atto.
Il cervello che si appanna per tutto il resto ma arde in nuclei di sofferenza, di ferite personali, di sogni perduti.


Se ti è piaciuto lascia un cuore!